| |
 Cicerone Cicerone
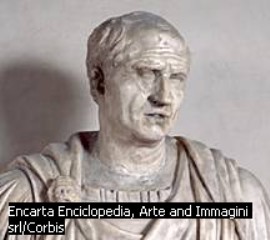
Cicerone, Marco Tullio (Arpino 106 a.C. - Formia 43 a.C.), oratore, uomo politico e
scrittore latino. Nacque in una famiglia ricca e influente dell'ordine equestre e fu avviato
agli studi di retorica, diritto e filosofia, prima a Roma e in seguito ad Atene, a Rodi e a
Smirne. Ritornato in patria nel 77 a.C., intraprese la carriera politica: divenne questore
nel 75 a.C., senatore nel 74, edile curule nel 69, pretore nel 66 e console nel 63.
A quest'ultima carica Cicerone arrivò grazie all'appoggio dei patrizi che diffidavano
dell'altro aspirante, l'aristocratico Lucio Sergio Catilina. Questi, sconfitto anche l'anno
seguente (62 a.C.), organizzò una vasta congiura, trovando appoggio soprattutto presso
gli aristocratici decaduti, i veterani di Silla e i proprietari terrieri cui erano stati
confiscati i beni. Cicerone, che riuscì a produrre in senato le prove della congiura, fece
arrestare e giustiziare alcuni cospiratori, tutti uomini di spicco a Roma. Ma lo stesso
comportamento di Cicerone, che agì affrettatamente e senza aver garantito agli accusati
un equo processo, venne condannato e gli costò l'esilio in Macedonia (58 a.C.); un anno
dopo riuscì a tornare a Roma grazie all'aiuto di Pompeo.
Costretto a restare lontano dalla vita politica dal triumvirato di Pompeo, Cesare e
Crasso, Cicerone si dedicò alla letteratura fino al 51 a.C., quando accettò la carica di
proconsole in Cilicia (Asia Minore). Di nuovo a Roma nel 50, affiancò Pompeo,
diventato nel frattempo nemico di Cesare. La sconfitta dei sostenitori di Pompeo a
Farsalo (48 a.C.) lo convinse a venire a patti con Cesare, che gli perdonò la passata
ostilità. Per qualche anno, fino all'uccisione di Cesare (44 a.C.), Cicerone rimase assente
dalla scena politica, dedicandosi agli studi filosofici e alla letteratura. Nel conflitto che
si accese tra il figlio adottivo di Cesare, Caio Ottaviano (che sarebbe stato insignito del
titolo di Augusto) e Marco Antonio, Cicerone si schierò dalla parte del primo, ma la
temporanea riconciliazione dei due nemici segnò la sua fine. Ottaviano non si oppose alla
decisione di Antonio di inserirlo nelle liste di proscrizione. Catturato presso Formia,
Cicerone venne giustiziato come nemico dello stato (43 a.C.).
Le orazioni di Cicerone ancora oggi conservate sono 58 (altre 48 sono andate perdute);
riguardano la sua attività di magistrato e di uomo politico e sono caratterizzate da una
prosa ricca e fluida che unisce chiarezza ed eloquenza. Le più note sono le quattro
Catilinarie e le Philippicae (I-XIV) contro Antonio. Fondamentali furono le sue opere
teoriche sulla retorica, che si rifanno a fonti greche oggi in gran parte perdute (ma
arricchite dell'esperienza di oratore dell'autore) e sono tra le più antiche in nostro
possesso. Quelle più importanti sono il De inventione, il De oratore, il Brutus
(una
storia dell'oratoria romana) e l'Orator, nelle quali Cicerone, tra l'altro, passò in rassegna
i vari stili di eloquenza, il grandioso, l'intermedio e il semplice, considerati non in scala
gerarchica bensì come tre diversi livelli fra i quali gli oratori potevano scegliere a
seconda delle cause trattate.
Dopo essersi dedicato solo saltuariamente agli studi filosofici, in seguito alla morte della
figlia Tullia (45 a.C.) fece convergere il suo interesse sulla speculazione etica,
ispirandosi alle grandi scuole della filosofia greca del tempo, quella stoica, quella
epicurea e quella accademica. L'eclettismo della sua opera filosofica rappresenta un
importante sforzo di ricapitolazione e assimilazione della cultura greca, ma ancora più
importante fu il fatto che, per compiere questa operazione, Cicerone fissò il linguaggio
filosofico latino. Tra le più importanti opere di contenuto filosofico e filosofico-politico
si ricordano: De republica, sullo stato e la migliore forma di governo, ossia una forma
mista di monarchia, oligarchia e democrazia; De finibus bonorum et malorum (Sui limiti
del bene e del male); De legibus, sulla natura religiosa e naturale delle leggi; De officiis
(Sui doveri), di ispirazione stoica, l'unica sua opera filosofica scritta non in forma di
dialogo; De natura deorum (Sulla natura degli dei); De divinatione; Laelius, de amicitia
(Lelio o sull'amicizia); Cato Maior, de senectute (Catone Maggiore o sulla vecchiaia).
Importantissime, perché informano sulla vita privata e pubblica di Cicerone e al tempo
stesso forniscono uno spaccato della vita del tempo, sono le oltre novecento Epistole
indirizzate agli amici, ai familiari, ai politici e agli intellettuali suoi contemporanei. Con
la sua prosa duttile, che sa essere magniloquente senza riuscire oscura ed è in grado di
trattare temi assai diversi – dalle minuzie quotidiane alle questioni etiche, dalle
argomentazioni filosofiche alle sottigliezze giuridiche e all'invettiva politica – Cicerone
stabilì i canoni della lingua colta ed ebbe un'immensa influenza sugli scrittori dei secoli
successivi, fino a Petrarca e alla letteratura del Rinascimento.
Microsoft ® Encarta ® Enciclopedia. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Tutti i
diritti riservati.
 |